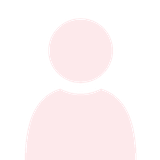Il 9 aprile 1945 il piroscafo americano “Henderson” saltò in aria per cause accidentali. Nello Stadio della Vittoria, i biancorossi, che il giorno prima avevano battuto il Matera, si stavano allenando…
Mancavano sedici giorni alla liberazione di Milano. Venti alla fine della guerra in Italia. Ventinove alla fine del secondo conflitto mondiale in Europa. Era il 9 aprile 1945. Alle 11.57 un boato scosse la città di Bari. L’onda d’urto fu violentissima. Distrusse vetri e vetrine. Il cielo diventò scuro. Cominciò a piovere nafta, mentre le urla di terrore si propagavano e pezzi enormi d’acciaio volavano qua e là. Che cosa era accaduto? Il piroscafo americano Charles Henderson, ormeggiato alla banchina 14 del porto in attesa di essere scaricato, era saltato in aria per cause accidentali. Anche se, in un primo momento, un sabotaggio non poté essere escluso. Provocò morte e distruzione nel raggio di chilometri.
la relazione ufficiale
—
“(…) Del piroscafo, che pochi minuti prima dominava con la sua mole la scena della calata, non restavano che due enormi spezzoni. La prua (…) e la poppa ridotta a un ammasso informe di ferraglie… Della parte centrale dello scafo non si scorgeva alcuna traccia” si lesse nella relazione ufficiale del Genio civile. Le conseguenze? Morti (317, di cui 142 dispersi), feriti gravi (1.732), altri, più lievi, non si recarono in ospedale e non furono registrati. Quasi mille famiglie (926 secondo i documenti ufficiali) furono “obbligate a trasferire la casa dichiarata inabitabile”, poiché le costruzioni erano state colpite dalle schegge metalliche dello scafo. Il passato recente tornò ad atterrire una città che chiedeva solo di vivere in pace.
precedenti
—
Il ricordo, del resto, era ancora vivido. Bari, dove la guerra pareva finita il 9 settembre 1943 – quando il generale Nicola Bellomo, pochi soldati e un manipolo di giovani del borgo antico avevano scacciato i tedeschi – rivisse le ore disperate seguite alle 19.25 del 2 dicembre 1943, quando un raid della Luftwaffe sul porto aveva affondato diciassette navi, tra le quali la John Harvey, carica di bombe all’iprite, uccidendo più di mille persone e ferendone migliaia. Lo scoppio del 9 aprile 1945 lesionò – tra gli altri edifici – la chiese di San Gregorio e Santa Chiara, l’ospizio di mendicità, la Cattedrale, la Basilica di San Nicola e anche la Chiesa Russa, distante cinque chilometri dal luogo dell’esplosione.
giornali e censura
—
L’Union Jack, il giornale alleato che si stampava in città, definì l’incidente “uno dei più gravi disastri della guerra nel teatro del Mediterraneo”. La Henderson – ma si seppe solo anni più tardi, quando la censura fu rimossa –, nelle stive aveva un carico di bombe. Non tutte convenzionali. C’erano anche ordigni all’iprite e al napalm. Gli alleati temevano che i tedeschi, ormai in rotta, avrebbero potuto usare per disperazione armi chimiche. A Foggia, la Wermacht, del resto, nel torrione centrale della cartiera, aveva allestito sin dal 1941, in gran segreto, la Saronio, un fabbrica di iprite e fosgene.

allenamento, paura, fuga
—
I giocatori del Bari che si stavano allenando allo Stadio della Vittoria, non lontano dal luogo della tragedia, scapparono negli spogliatoi. Il catino, inaugurato nel 1934, era già stato colpito dalla Luftwaffe nel raid aereo del 1943, provocando una profonda fenditura nel tetto che copriva le tribune. Il 9 aprile 1945 venne soltanto sfiorato dai resti della nave propagatisi per una raggio di oltre cinque chilometri dal luogo dell’incidente. Il giorno prima, il Bari vi aveva travolto il Matera (4-1) nell’undicesimo turno del “torneo misto”. Lucani avanti con Melica, poi due gol di Camillo Fabbri, fratello di Mondino – futuro c.t. azzurro nel disastro Mondiale di Middlesbrough 1966 con la Corea del Nord -, e altrettanti di Piero Colli, un centrocampista dai piedi raffinati, avevano rimesso le cose a posto.

catino multiuso
—
Il cuore pulsante dello sport cittadino era lì. Nello Stadio della Vittoria. Era stato restituito al calcio da poco più di un mese (4 marzo) in occasione del derby vinto (2-1) dai biancorossi sul Lecce. Il 23 novembre 1944 aveva ospitato il Bambino Bowl, il primo match di football americano in Italia, nonché una sorta di Superbowl oraginizzato dagli alleati, che l’avevano usato per accamparsi durante la campagna d’Italia. Le nicchie intorno allo stadio erano invece state usate come riparo dei muli o dei pochi carri armati italiani durante l’improvvisata occupazione dell’Albania e la disastrosa campagna di Grecia. Immagini che sembravano lontane. Rimosse. Come i lutti, le distruzioni, la miseria causati da una guerra sbagliata e persa in partenza. Invece riemersero nella memoria collettiva di una città intera. Mancavano sedici giorni alla liberazione di Milano. Venti alla fine della guerra in Italia. Ventinove alla fine del secondo conflitto mondiale in Europa. Era il 9 aprile 1945. Ottanta anni fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA